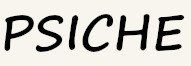Le funzioni della mente umana
Conoscere e apprendere. Differenziarsi e definire la propria identità. Relazionarsi agli altri. Gestire le pulsioni. Adattarsi ed essere resilienti. Seguire valori e ideali. Dare significato alla propria vita.

Ogni soggetto umano, in quanto dotato di cervello, possiede una serie di funzioni mentali, il cui diverso sviluppo e organizzazione definisce poi la struttura psichica di ciascun individuo nella sua particolarità.
Tali funzioni sono riconducibili a quattro ambiti generali:
- ambito dei processi cognitivi e affettivi (capacità di attenzione e apprendimento, capacità di sperimentare, comprendere e comunicare gli affetti, capacità di mentalizzare)
- ambito dell’identità e delle relazioni (capacità di differenziazione e integrazione, la capacità di relazione e intimità e la regolazione dell’autostima)
- ambito delle difese e del coping (capacità di controllo - intesa come regolazione degli impulsi, funzionamento dei meccanismi difensivi, capacità di adattamento e resilienza)
- ambito dell’autoconsapevolezza e autodirezionalità ( la capacità di auto-osservazione, la capacità di costruire e ricorrere a ideali, la capacità di dare significato e direzione alla propria vita)
Vediamo in cosa consistono tali funzioni una ad una.
PROCESSI COGNITIVI E AFFETTIVI
Capacità di attenzione e apprendimento: percepire ed elaborare informazioni (uditive, linguistiche, visuo- spaziali, motorie), regolare il focus attentivo, distribuire l’attenzione (multi-tasking), filtrare le informazioni non necessarie e apprendere dalle proprie esperienze (modificare il comportamento)
Capacità di sperimentare, comprendere e comunicare gli affetti: sperimentare la gamma di stati affettivi ed emotivi, sia positivi sia negativi, di diversa intensità; riconoscere e comunicare ad altri la propria esperienza emotiva e affettiva in modo efficace e adattivo con modalità appropriate alla situazione, alle norme e alle aspettative del proprio contesto sociale. Un basso funzionamento comporta oltre che la difficoltà di identificare, differenziare, comunicare i propri sentimenti, anche la mancanza di immaginazione, una funzione psichica orientata all’esterno. La capacità immaginativa è fortemente influenzata dalla prime interazioni fra caregiver e bambino ed è connessa alla cognizione sociale.
Capacità di mentalizzare: riflettere sugli stati mentali (emotivi, cognitivi e comportamentali) propri e altrui, formando rappresentazioni di sé e degli altri; è legata alla capacità immaginativa, è preconscia e finalizzata a comprendere e interpretare il comportamento in termini di stati mentali. Questa capacità consente all’individuo di utilizzare tali rappresentazioni nelle interazioni interpersonali, permette di descrivere ed esprimere il mondo interiore, di fare inferenze sugli stati mentali altrui, di regolare gli affetti e sviluppare un senso di sé coerente.
IDENTITÀ E RELAZIONI
Capacità di differenziazione e integrazione: distinguere il sé dall’altro, la fantasia dalla realtà, le rappresentazioni interne dagli oggetti esterni e dalle circostanze, il passato dal futuro e dal presente; mantenere una rappresentazione differenziata, realistica, coerente e complessa di sé e degli altri e creare collegamenti tra queste rappresentazioni.
Capacità di relazione e intimità: regolare la distanza – vicinanza in modo adeguato, a seconda dei rapporti e della cultura di appartenenza. Instaurare relazioni caratterizzate da diversità, profondità e stabilità. Una relazionalità matura dipende dal grado di relazioni stabili e mutualmente soddisfacenti, ma anche nella qualità dell’immagine che si ha di sé, degli altri e di se con gli altri. Include la sessualità, ovvero la consapevolezza dei propri desideri ed emozioni, la capacità di coinvolgersi in fantasie e attività sessuali soddisfacenti e di integrare la sessualità con l’emotività.
Regolazione dell’autostima: grado di sicurezza e autostima che caratterizza la relazione dell’individuo con se stesso, con gli altri e con il mondo. Un funzionamento ottimale consiste nel mantenere l’equilibrio tra l’autostima derivata dalla auto-valutazione di sé e quella derivata dallo specchio e dai rimandi degli altri. La regolazione dell’autostima include il controllo dei propri impulsi e la capacità di ottenere risultati dalle proprie azioni (autoefficacia) e di agire in modo trasformativo sugli eventi, anziché subirli passivamente.
DIFESE E COPING
Capacità di controllo (intesa come regolazione degli impulsi): regolazione degli impulsi ed espressione degli stessi in modalità adeguate all’ambiente sociale e della cultura di appartenenza. La compromissione di questa capacità può comportare l’espressione rigida o il controllo degli impulsi (inibizione) e affettività coartata: fenomeno che vede la persona solo apparentemente distante, distaccata e disinteressata, quando in realtà non sa come esprimere le emozioni che prova.
Funzionamento dei meccanismi difensivi : modalità di gestione degli impulsi, dei desideri, dei conflitti interni; capacità di modulare l’ansia derivante da conflitti interni o da sfide esterne (sublimazione, proiezione, identificazione, rimozione,...) senza ricorrere a distorsioni della percezione di sé e dell’esame di realtà (psicosi), o ad un uso eccessivo di acting out (azioni aggressive e impulsive utilizzate dall’individuo per esprimere vissuti conflittuali e inesprimibili attraverso la parola e comunicabili solo attraverso l’agito)
Capacità di adattamento e resilienza: capacità di adattarsi all’imprevisto e al cambiamento, capacità di reggere e superare l’incertezza, la perdita, lo stress e le sfide della vita. Può includere l’empatia, il riconoscimento dei punti di vista alternativi e l’assertività.
AUTOCONSAPEVOLEZZA E AUTODIREZIONALITÀ
Capacità di auto-osservazione: capacità di osservare la propria vita mentale interiore in modo consapevole e realistico, comporta una maggiore consapevolezza di sé
Capacità di costruire e ricorrere a ideali: costituisce il senso morale di un individuo. É la capacità dei soggetti di formulare i propri valori e ideali, la capacità di prendere decisioni consapevoli basate su un insieme coerente, flessibile e integrato di principi morali e la consapevolezza dell’impatto che le proprie decisioni hanno sulle altre persone. La capacità dei soggetti di formulare i propri valori e ideali rispecchia la percezione che si ha di sé all’interno del contesto culturale di appartenenza.
Capacità di dare significato e direzione alla propria vita: capacità di costruire una narrazione personale di sé, in grado di fornire coerenza e significato alle proprie scelte e un senso di direzionalità e progettualità. Ad alto funzionamento, questa capacità consente all’individuo di pensare al di là delle preoccupazioni immediate.
Lingiardi, McWilliams,
PDM-2, manuale diagnostico psicodinamico, Raffaello Cortina 2020 (asse M, pag.83-4; 129; 85-126)